 Sale Sala I Sala II Sala III Sala IV Sala V Sala VI Sala VII Sala VIII |
Museo Archeologico di
Pithecusae
|
| *Preistoria* | VIII-VII sec. | VI-IV sec. | Età Ellenistica | Età Romana |

SALA I - Vetrina 3
LA MEDIA ETA' DEL BRONZO 1400-1300 a. C.
|
Ceramica Micenea
Insieme con il materiale ceramico d'impasto che rientra, per forma e decorazione, nel quadro della c.d. Civiltà Appenninica (diffusasi lungo la dorsale appenninica dell'Italia Centrale ed in parte di quella Meridionale), uno dei dati più significativi offerti dallo scavo dell'abitato di Castiglione, pur nella limitatezza delle indagini che vi sono state effettuate, è stato il rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica micenea, particolarmente importanti anche per la storia degli studi, perché hanno costituito la prima testimonianza della presenza micenea lungo le coste del Mar Tirreno.
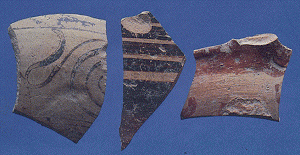 |
Frammenti di ceramica micenea, dalla località Castiglione (Casamicciola). Età del Bronzo (Civiltà Appenninica, 1400 a. C. ca.) VETRINA III |
I frammenti di Castiglione [vetrina 3: un frammento di spalla di giara (tipo FS 44-5) un altro, analogo (tipo FS 30) ed un orlo di tazza con attacco dell'ansa (tipo FS 253)], tutti databili al Miceneo III A (1425-1300 ca. a.C.), attestano dunque come fossero esistiti degli scambi commerciali con il mondo egeo già qualche secolo prima della colonizzazione greca e come la nascente società micenea, che cominciava ad affermarsi come gruppo dominante nella Grecia continentale, possedesse una dinamica tale da creare una rete commerciale estesa a tutto il bacino del Mediterraneo centro-meridionale, come insegnano, insieme con i ritrovamenti ischitani, quelli molto più numerosi del vicino isolotto di Vivara, della Puglia (lungo la costa adriatica, dal promontorio del Gargano in giù ed intorno al Golfo di Taranto), del versante ionico della Basilicata e della Calabria, della Sicilia orientale e delle isole Eolie, oltre che delle coste della Sardegna. Il fatto che i primi interessi micenei all'estero puntino all'Occidente sta ad indicare forse l'urgente bisogno di trovare nuove zone metallifere, ma soprattutto come, per i Micenei in fase di formazione, l'accesso all'ambiente tirrenico-meridionale costituisse la più facile delle scelte.
Decorazione dei vasi (spirale e meandro)
La ceramica micenea trovata ad Ischia ha consentito anche di datare con maggior precisione la facies culturale indigena, inquadrabile nella fase più evoluta del Bronzo Medio, e cioè nella fase appenninica propriamente detta, contraddistinta, nella cultura materiale, dalla classica e ricca decorazione dei vasi con motivi profondamente incisi - tra i quali predominano la spirale ed il meandro - o intagliati, asportando una parte della superficie che veniva poi fatta risaltare con il riempimento di pasta bianca, talvolta ancora conservata (tecnica dell'excisione).
Tipologia dei vasi
Sono frequenti le tipiche scodelle e tazze, con profilo raramente arrotondato (inv. 233396) quasi sempre fortemente carenato, qualcuna anche con il fondo ombelicato (inv. 233395). Le anse verticali presentano, per lo più, un foro triangolare con la punta rivolta verso l'alto o verso il basso (inv. 233394, inv. 233395), più raramente un foro rotondo (inv. 233398). Le forme delle anse stesse variano, da esemplari con orli laterali convergenti, l'estremità profondamente insellata e gli apici ben distinti e revoluti, sino ad esemplari con orli laterali paralleli, senza insellatura del margine superiore e quindi senza apici distinti.
Un tipo particolare è costituito da scodelle molto grandi, con profilo arrotondato ed ansa con tre fori triangolari, quello mediano più grande, con la punta rivolta verso il basso, i laterali con la punta verso l'alto (inv. 233396). Mancano le anse ad anello, sormontate da appendici diverse, mentre sono frequenti altri vasi di piccola e media grandezza, soprattutto olle, per lo più biansate con collo cilindrico o troncoconico e ventre globulare, tra le quali si segnala un esemplare con ansa a maniglia semicircolare a bastoncello e decorazione incisa con motivo a zigzag e fascia a meandro continuo (inv. 233393).
 |
Scodellone d'impasto, dalla località Castiglione (Casamicciola la). Età del Bronzo (civiltà appenninica, 1400 a.C. ca.) VETRINA III |
La ceramica incisa, come avviene del resto nella maggior parte delle stazioni appenniniche, è relativamente scarsa rispetto alla grande quantità di quella inornata. E' esposto un frammento di grande vaso con decorazione incisa costituita, sul collo, da motivi angolari in parte puntinati e, sulla spalla, da motivi spiraliformi (inv. 233394).
Tecniche di lavorazione
Tutto questo vasellame è modellato a mano libera, senza l'aiuto del tornio; le pareti dei vasi sono state costruite sovrapponendo strisce più o meno larghe di argilla, sistema ancora molto diffuso presso tutte le popolazioni primitive; anse e decorazioni plastiche venivano modellate separatamente e poi inserite o applicate al vaso. Per diminuire la contrazione dell'argilla durante la cottura ed evitare quindi il pericolo che i vasi si spaccassero, l'argilla era "sgrassata", cioè impastata con sabbia. La superficie dei vasi più fini, dopo che il vaso era stato fatto asciugare all'aria, veniva accuratamente levigata con la stecca o con un brunitoio di pietra. La cottura avveniva a fuoco aperto o in fornaci molto primitive, che raggiungevano solo eccezionalmente il grado di calore necessario per ottenere una cottura completa (da 960° in poi). Questo dà ragione del colore di questi vasi che non è mai quello rosso o giallo dell'argilla ben cotta ma grigio, bruno o nerastro.
Rondelle circolari
Insieme con la ceramica si sono rinvenute, a Castiglione, anche delle rondelle di forma circolare - esposte nella vetrina 3 - ricavate da cocci, che si ritrovano identiche anche nell'abitato dell'Età del Bronzo di Vivara, dell'Età del Ferro preellenica dello stesso Castiglione, nell'abitato greco di Lacco Ameno dell'VII sec. e sino all'età ellenistica, mentre altre rondelle appaiono ricavate da tegole o da cocci di età romana. Esse attesterebbero, secondo alcuni autori (da ultimo, Giuseppina Mammina-Massimiliano Marazzi-Sebastiano Tusa, 1990), l'esistenza di un sistema di computo a mezzo di "gettoni" fittili. Secondo Giorgio Buchner, invece, esse costituirebbero la testimonianza di un antichissimo gioco che, sino agli anni intorno al 1960, i ragazzi giocavano ancora nelle strade, utilizzando queste piastrelle dette appunto "pastore". Un bando emanato da Ferdinando IV nel 1764, inciso su di una lastra di marmo ancora murata sulla facciata della Chiesa di S. Domenico Maggiore, a Napoli, ordinava a tutti, di qualsiasi grado, che "non ardiscano ne presumino giocare a carte, palle, farinole e qualsiasi altra sorte di gioco e nemmeno schiassare" su quella piazza.
![]()